|
 Nel suo dodicesimo anno di vita il Far East Film Festival di Udine presenta 72 film, tra programma principale e retrospettive, provenienti da 9 paesi del lontano oriente, a partire da Giappone, Cina, Corea, Hong Kong e Taiwan, fino ad arrivare al sud est asiatico rappresentato da Thailandia, Vietnam, Indonesia e Filippine. La selezione per la sezione principale del festival si è assestata ad un livello discreto, con una serie di film confezionati in maniera impeccabile, ma non ha registrato, purtroppo, la presenza di opere memorabili, capaci di fissarsi a lungo nella mente degli spettatori. Nel suo dodicesimo anno di vita il Far East Film Festival di Udine presenta 72 film, tra programma principale e retrospettive, provenienti da 9 paesi del lontano oriente, a partire da Giappone, Cina, Corea, Hong Kong e Taiwan, fino ad arrivare al sud est asiatico rappresentato da Thailandia, Vietnam, Indonesia e Filippine. La selezione per la sezione principale del festival si è assestata ad un livello discreto, con una serie di film confezionati in maniera impeccabile, ma non ha registrato, purtroppo, la presenza di opere memorabili, capaci di fissarsi a lungo nella mente degli spettatori.
 Dal Giappone provengono due tra le pellicole migliori proiettate quest’anno. The Accidental Kidnapper di Sakaki Hideo, secondo nella classifica di gradimento del pubblico, racconta con molta ironia e leggerezza le disavventure di un improvvisato rapitore. La vittima prescelta, un bambino figlio di un boss yakuza, si dimostrerà molto più furba del previsto, e i due protagonisti si ritroveranno uniti da un profondo legame di amicizia e di complicità. Il tono pacato, che permea tutto il film e ha il pregio di non virare mai in uno scontato sentimentalismo, viene purtroppo a mancare nel finale, in cui il climax narrativo, dilungandosi eccessivamente, si rivela parzialmente artificioso. Miura Daisuke firma invece Boys on the Run, feroce commedia che con sguardo impietoso segue le disavventure sentimentali di un ventinovenne ancora alle prese con i problemi tipici dell’età adolescenziale. Si ride di gusto per tutta la durata del film: Daisuke ha un senso del ritmo e del tempo comico non comuni. Ma il sorriso non può che tramutarsi in una smorfia di amarezza all’emergere del ritratto di una generazione sconfitta, incapace di affermarsi sulla realtà a causa della propria inettitudine: nessun riscatto possibile per il protagonista, i cui desideri sono destinati alla fine ad evaporare come al risveglio da un lungo sogno. Dal Giappone provengono due tra le pellicole migliori proiettate quest’anno. The Accidental Kidnapper di Sakaki Hideo, secondo nella classifica di gradimento del pubblico, racconta con molta ironia e leggerezza le disavventure di un improvvisato rapitore. La vittima prescelta, un bambino figlio di un boss yakuza, si dimostrerà molto più furba del previsto, e i due protagonisti si ritroveranno uniti da un profondo legame di amicizia e di complicità. Il tono pacato, che permea tutto il film e ha il pregio di non virare mai in uno scontato sentimentalismo, viene purtroppo a mancare nel finale, in cui il climax narrativo, dilungandosi eccessivamente, si rivela parzialmente artificioso. Miura Daisuke firma invece Boys on the Run, feroce commedia che con sguardo impietoso segue le disavventure sentimentali di un ventinovenne ancora alle prese con i problemi tipici dell’età adolescenziale. Si ride di gusto per tutta la durata del film: Daisuke ha un senso del ritmo e del tempo comico non comuni. Ma il sorriso non può che tramutarsi in una smorfia di amarezza all’emergere del ritratto di una generazione sconfitta, incapace di affermarsi sulla realtà a causa della propria inettitudine: nessun riscatto possibile per il protagonista, i cui desideri sono destinati alla fine ad evaporare come al risveglio da un lungo sogno.
 La selezione di Hong Kong quest’anno non soddisfa pienamente. La presenza di molti action movies di discreto livello non riesce a togliere la sensazione che si sia persa un’occasione per dare una visione più articolata della cinematografia attuale di questo paese. Fa eccezione il film di Derek Kwok e Clement Cheng, Gallants, che con una freschezza e un ritmo impressionanti, mette in scena dietro una patina nostalgica il grande kung fu del periodo d’oro di Hong Kong. Gli eroi al tramonto, ormai alle prese col decadimento del proprio corpo e con la consapevolezza di non poter essere più quello che erano stati all’apice della loro esistenza, sono colti con un’ironia esemplare che regala momenti di comicità esilarante. Di buona fattura, ma molto lontani dall’impatto emotivo che il grande cinema hongkonghese era capace di suscitare negli anni passati, si sono rivelati Bodyguard and Assassins di Teddy Chen e Little Big Soldier di Ding Sheng. Il primo, risultato di una co-produzione Cina/Hong Kong, cala nella cornice dell’evento storico un classico film di arti marziali, mentre il secondo si rifugia in epoche leggendarie, non riuscendo però, nonostante una confezione assolutamente godibile, avvalorata dalla performance di Jackie Chan, a far respirare al pubblico aria di vera epica. La selezione di Hong Kong quest’anno non soddisfa pienamente. La presenza di molti action movies di discreto livello non riesce a togliere la sensazione che si sia persa un’occasione per dare una visione più articolata della cinematografia attuale di questo paese. Fa eccezione il film di Derek Kwok e Clement Cheng, Gallants, che con una freschezza e un ritmo impressionanti, mette in scena dietro una patina nostalgica il grande kung fu del periodo d’oro di Hong Kong. Gli eroi al tramonto, ormai alle prese col decadimento del proprio corpo e con la consapevolezza di non poter essere più quello che erano stati all’apice della loro esistenza, sono colti con un’ironia esemplare che regala momenti di comicità esilarante. Di buona fattura, ma molto lontani dall’impatto emotivo che il grande cinema hongkonghese era capace di suscitare negli anni passati, si sono rivelati Bodyguard and Assassins di Teddy Chen e Little Big Soldier di Ding Sheng. Il primo, risultato di una co-produzione Cina/Hong Kong, cala nella cornice dell’evento storico un classico film di arti marziali, mentre il secondo si rifugia in epoche leggendarie, non riuscendo però, nonostante una confezione assolutamente godibile, avvalorata dalla performance di Jackie Chan, a far respirare al pubblico aria di vera epica.
 È cinese una delle opere più complesse e profonde presentate nella sezione principale del festival. City of Life and Death di Lu Chuan ha il merito di non eccedere nel patriottismo nel riproporre il massacro di Nanchino, ferita ancora aperta nella coscienza del popolo cinese. In uno splendido bianco e nero, l’invasione giapponese è mostrata in tutta la sua efferatezza. Il regista non indietreggia nel mostrare la ferocia con cui l’esercito giapponese compì ogni genere di atrocità sugli abitanti di Nanchino ergendosi a simbolo dell’irrazionalità della guerra. Tuttavia, nel soldato giapponese non si scorge soltanto il nemico, ma si intravede l’uomo, con la sua fierezza, il suo senso del dovere, la sua crudeltà, i suoi dubbi, il suo senso di colpa. Tra i vari paesi presenti quest’anno in rappresentanza del sud est asiatico spicca la Thailandia con ben 5 film in programma. Ed è thailandese l’horror più interessante visto quest’anno: Slice di Kongkiat Khomsiri, già presentato al Bruxelles International Fantastic Film Festival 2010, si fa notare soprattutto sotto l’aspetto visivo, che rimanda al grande cinema horror italiano degli anni Settanta di Mario Bava e Dario Argento. Attraverso l’uso di blu e rossi molto saturi prende vita un paesaggio dall’atmosfera allucinatoria che fa da sfondo agli efferati delitti di un serial killer. Se nella parte iniziale il film di Khomsiri si presenta nelle vesti di un classico slasher movie dalle tinte molto forti e dalle connotazioni morbose, col proseguire della narrazione cambia di registro, raccontando la storia di un’infanzia perduta e di un sentimento nascente. Il finale sorprende per il pathos che riesce a trasmettere allo spettatore, portando alla luce un amore impossibile e irrealizzabile se non nella morte. Non convince totalmente, invece, il film indonesiano The Dreamer di Riri Riza, che si affida ad un utilizzo eccessivo della voce fuori campo, con l’effetto di appesantire ingiustificatamente la narrazione. Il nucleo tematico, realizzare i propri sogni è pur sempre possibile, è inoltre trattato con troppo sentimentalismo, risultando a tratti scontato e irritante. Per finire, nella sezione sudcoreana il film di Lee Hey-jun, Castaway on the Moon, vince il premio del pubblico e il Black Dragon Award. Mr. Kim, dopo un tentato e fallito suicidio, si ritrova bloccato su un’isoletta deserta al centro del fiume Han. Reinvenzione del mito di Robinson Crusoe, più vicina forse all’isola di cemento di James G. Ballard che al romanzo di Defoe, il film fa ripartire il suo protagonista dai rifiuti e dagli scarti della civiltà avanzata, mentre, in un lontano palazzo, una ikikomori inizia grazie a lui a riprendere contatto con il mondo esterno. L’opera di Lee procede con originalità verso l’incontro finale tra i due protagonisti, entrambi da troppo tempo rinchiusi nelle loro reciproche solitudini, ma disposti forse a rimettersi in gioco ancora per una volta. È cinese una delle opere più complesse e profonde presentate nella sezione principale del festival. City of Life and Death di Lu Chuan ha il merito di non eccedere nel patriottismo nel riproporre il massacro di Nanchino, ferita ancora aperta nella coscienza del popolo cinese. In uno splendido bianco e nero, l’invasione giapponese è mostrata in tutta la sua efferatezza. Il regista non indietreggia nel mostrare la ferocia con cui l’esercito giapponese compì ogni genere di atrocità sugli abitanti di Nanchino ergendosi a simbolo dell’irrazionalità della guerra. Tuttavia, nel soldato giapponese non si scorge soltanto il nemico, ma si intravede l’uomo, con la sua fierezza, il suo senso del dovere, la sua crudeltà, i suoi dubbi, il suo senso di colpa. Tra i vari paesi presenti quest’anno in rappresentanza del sud est asiatico spicca la Thailandia con ben 5 film in programma. Ed è thailandese l’horror più interessante visto quest’anno: Slice di Kongkiat Khomsiri, già presentato al Bruxelles International Fantastic Film Festival 2010, si fa notare soprattutto sotto l’aspetto visivo, che rimanda al grande cinema horror italiano degli anni Settanta di Mario Bava e Dario Argento. Attraverso l’uso di blu e rossi molto saturi prende vita un paesaggio dall’atmosfera allucinatoria che fa da sfondo agli efferati delitti di un serial killer. Se nella parte iniziale il film di Khomsiri si presenta nelle vesti di un classico slasher movie dalle tinte molto forti e dalle connotazioni morbose, col proseguire della narrazione cambia di registro, raccontando la storia di un’infanzia perduta e di un sentimento nascente. Il finale sorprende per il pathos che riesce a trasmettere allo spettatore, portando alla luce un amore impossibile e irrealizzabile se non nella morte. Non convince totalmente, invece, il film indonesiano The Dreamer di Riri Riza, che si affida ad un utilizzo eccessivo della voce fuori campo, con l’effetto di appesantire ingiustificatamente la narrazione. Il nucleo tematico, realizzare i propri sogni è pur sempre possibile, è inoltre trattato con troppo sentimentalismo, risultando a tratti scontato e irritante. Per finire, nella sezione sudcoreana il film di Lee Hey-jun, Castaway on the Moon, vince il premio del pubblico e il Black Dragon Award. Mr. Kim, dopo un tentato e fallito suicidio, si ritrova bloccato su un’isoletta deserta al centro del fiume Han. Reinvenzione del mito di Robinson Crusoe, più vicina forse all’isola di cemento di James G. Ballard che al romanzo di Defoe, il film fa ripartire il suo protagonista dai rifiuti e dagli scarti della civiltà avanzata, mentre, in un lontano palazzo, una ikikomori inizia grazie a lui a riprendere contatto con il mondo esterno. L’opera di Lee procede con originalità verso l’incontro finale tra i due protagonisti, entrambi da troppo tempo rinchiusi nelle loro reciproche solitudini, ma disposti forse a rimettersi in gioco ancora per una volta.
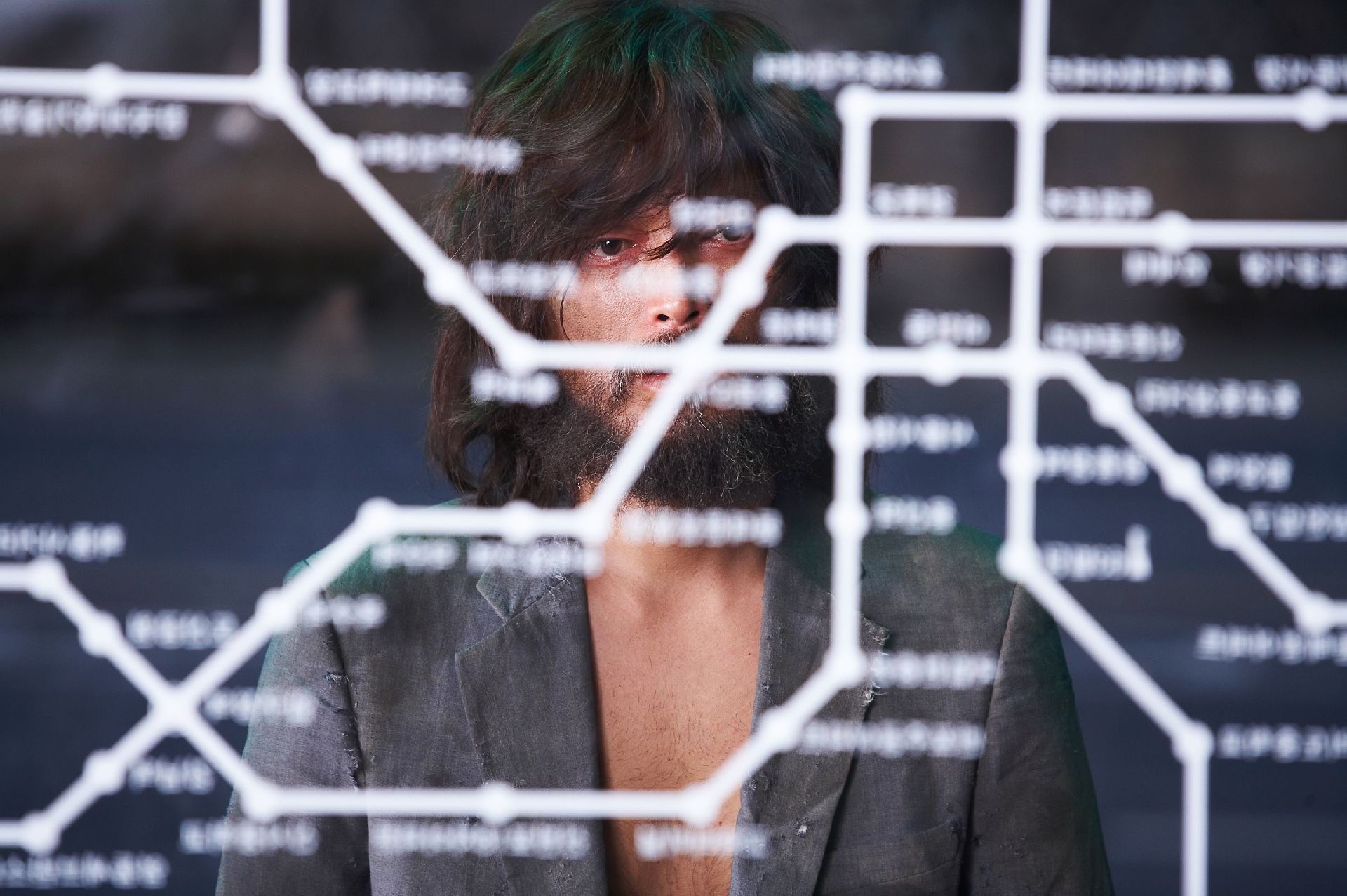 Se il bilancio della sezione principale del festival segnala la mancanza di una dimensione autoriale forte, capace di uscire dalle logiche puramente di genere e di fornire agli spettatori uno sguardo più profondo e articolato sulla realtà, le due retrospettive in programma, dedicate l’una a un maestro del cinema honkonghese degli anni Sessanta, Patrick Lung Kong, l’altra alla casa di produzione giapponese Shin-Toho, hanno riservato continue ed inattese emozioni. Patrick Lung Kong, attore, sceneggiatore e regista, ha diretto 12 film a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, portando all’interno del cinema hongkonghese dell’epoca un rinnovamento che ha profondamente influenzato i registi della generazione successiva, protagonisti della new wave. A lui il Far East ha dedicato un programma di 7 film, dopo che già l’Hong Kong Film Festival di quest’anno gli aveva riservato una retrospettiva completa. Il cinema di Lung Kong, impregnato di un forte sentimento religioso, al limite del proselitismo, ha il merito di aver introdotto per la prima volta nel cinema in lingua cantonese scottanti tematiche sociali, legate soprattutto al problema dei disadattati, persone ai margini della società, ex-detenuti, criminali, poveri e prostitute, e al loro difficile, se non impossibile (re)inserimento sociale. Questa ricognizione sulle zone più in ombra della vita sociale viene spesso accompagnata da una ricerca eziologica delle motivazioni alla base dei comportamenti socialmente devianti e dal tentativo di mostrare una via alternativa alla punizione per la loro non facile correzione. A volte il discorso morale di Lung Kong si fa troppo esplicito, ai limiti del didascalismo, ma nei suoi film migliori esso viene relegato a particolari istanze della narrazione, a figure di contorno incaricate di esporre il messaggio dell’autore, senza contaminare tuttavia la struttura complessiva della storia, che rimane permeata di un profondo nichilismo e pessimismo esitenziale. Se il bilancio della sezione principale del festival segnala la mancanza di una dimensione autoriale forte, capace di uscire dalle logiche puramente di genere e di fornire agli spettatori uno sguardo più profondo e articolato sulla realtà, le due retrospettive in programma, dedicate l’una a un maestro del cinema honkonghese degli anni Sessanta, Patrick Lung Kong, l’altra alla casa di produzione giapponese Shin-Toho, hanno riservato continue ed inattese emozioni. Patrick Lung Kong, attore, sceneggiatore e regista, ha diretto 12 film a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, portando all’interno del cinema hongkonghese dell’epoca un rinnovamento che ha profondamente influenzato i registi della generazione successiva, protagonisti della new wave. A lui il Far East ha dedicato un programma di 7 film, dopo che già l’Hong Kong Film Festival di quest’anno gli aveva riservato una retrospettiva completa. Il cinema di Lung Kong, impregnato di un forte sentimento religioso, al limite del proselitismo, ha il merito di aver introdotto per la prima volta nel cinema in lingua cantonese scottanti tematiche sociali, legate soprattutto al problema dei disadattati, persone ai margini della società, ex-detenuti, criminali, poveri e prostitute, e al loro difficile, se non impossibile (re)inserimento sociale. Questa ricognizione sulle zone più in ombra della vita sociale viene spesso accompagnata da una ricerca eziologica delle motivazioni alla base dei comportamenti socialmente devianti e dal tentativo di mostrare una via alternativa alla punizione per la loro non facile correzione. A volte il discorso morale di Lung Kong si fa troppo esplicito, ai limiti del didascalismo, ma nei suoi film migliori esso viene relegato a particolari istanze della narrazione, a figure di contorno incaricate di esporre il messaggio dell’autore, senza contaminare tuttavia la struttura complessiva della storia, che rimane permeata di un profondo nichilismo e pessimismo esitenziale.
 Così Story of a Discharged Prisoner, Teddy Girls e Call Girls mettono tutti in scena personaggi senza speranza, uomini e donne per cui il passato costituisce una macchia impossibile da cancellare e un destino che ne predetermina inevitabilmente il futuro. In Story of a Discharged Prisoner, da cui John Woo ha tratto spunto per il suo A Better Tomorrow, il protagonista è un giovane appena uscito dal carcere perseguitato da un boss della malavita locale che lo vuole al suo servizio. Ogni suo tentativo di reinserimento sociale è condannato a naufragare fino all’ineluttabile ritorno in carcere. Oltre alla novità della tematica trattata, visivamente l’opera si segnala per il frequente ricorso all’uso della camera a mano che riesce a donare alle scene d’azione un dinamismo non comune nel cinema hongkonghese dell’epoca. Ma è in Call Girls che la visione si fa totalmente disperata. “Once a whore, always a whore” è il giudizio impietoso che una prostituta dà di se stessa e che riassume il senso di tutto il film: Dio è completamente assente e per le donne condannate alla vita da strada non c’è più nemmeno la speranza di un’esistenza futura in qualche modo migliore. Le vicende di cinque prostitute sono raccontate attraverso un frenetico quanto mai fluido montaggio incrociato, che riduce al minimo la percezione delle transizioni tra le varie storie e dona unità dal punto di vista formale alla frammentazione narrativa del contenuto. Così Story of a Discharged Prisoner, Teddy Girls e Call Girls mettono tutti in scena personaggi senza speranza, uomini e donne per cui il passato costituisce una macchia impossibile da cancellare e un destino che ne predetermina inevitabilmente il futuro. In Story of a Discharged Prisoner, da cui John Woo ha tratto spunto per il suo A Better Tomorrow, il protagonista è un giovane appena uscito dal carcere perseguitato da un boss della malavita locale che lo vuole al suo servizio. Ogni suo tentativo di reinserimento sociale è condannato a naufragare fino all’ineluttabile ritorno in carcere. Oltre alla novità della tematica trattata, visivamente l’opera si segnala per il frequente ricorso all’uso della camera a mano che riesce a donare alle scene d’azione un dinamismo non comune nel cinema hongkonghese dell’epoca. Ma è in Call Girls che la visione si fa totalmente disperata. “Once a whore, always a whore” è il giudizio impietoso che una prostituta dà di se stessa e che riassume il senso di tutto il film: Dio è completamente assente e per le donne condannate alla vita da strada non c’è più nemmeno la speranza di un’esistenza futura in qualche modo migliore. Le vicende di cinque prostitute sono raccontate attraverso un frenetico quanto mai fluido montaggio incrociato, che riduce al minimo la percezione delle transizioni tra le varie storie e dona unità dal punto di vista formale alla frammentazione narrativa del contenuto.
 La Shin-Toho nasce nel 1947 come ramo produttivo secondario della casa madre Toho, e in soli 14 anni di vita, prima del tracollo finanziario, produce all’incirca 800 pellicole. Se nella prima fase della sua vita, la Shin-Toho si dedica a una produzione molto variegata, focalizzandosi anche su un certo cinema d’autore (da Vita di O-haru donna galante di Kenji Mizoguchi a Cane randagio di Akira Kurosawa), a partire dal 1955 il regime produttivo cambia drasticamente, grazie all’arrivo di Mitsugu Okura, che dà una svolta molto più commerciale alla linea di produzione. È proprio su questa seconda fase, imperniata su un cinema di genere, che va dall’horror al noir, dal gangster movie all’ama (ragazze in bikini), che la selezione del Far East si focalizza, mostrando ben 15 film, la maggior parte dei quali sconosciuti e mai proiettati in Occidente. Da questo programma provengono senza dubbio le opere migliori proiettate al festival quest’anno. A partire da The Horizon Glitters di Doi Michiyoschi, resoconto di una rocambolesca evasione e di un viaggio alla ricerca di un fantomatico tesoro. Cinque criminali fuggono dal carcere, spinti dal desiderio di recuperare un bottino che uno di loro ha nascosto prima di venire arrestato: in un continuo alternarsi di momenti comici, episodi al limite del surreale, ed eventi di una ferocia estrema, i cinque protagonisti arrivano all’inesorabile scoperta della vanità della loro ricerca. Film di un nichilismo spiazzante, raccontato per buona parte con toni da farsa picaresca e impregnato a tratti di una tensione dionisiaca riflessa in un uso frenetico del montaggio, mette in luce come l’avidità e il miraggio della ricchezza riconducano l’uomo alla sua natura bestiale e ai suoi istinti primordiali. La Shin-Toho nasce nel 1947 come ramo produttivo secondario della casa madre Toho, e in soli 14 anni di vita, prima del tracollo finanziario, produce all’incirca 800 pellicole. Se nella prima fase della sua vita, la Shin-Toho si dedica a una produzione molto variegata, focalizzandosi anche su un certo cinema d’autore (da Vita di O-haru donna galante di Kenji Mizoguchi a Cane randagio di Akira Kurosawa), a partire dal 1955 il regime produttivo cambia drasticamente, grazie all’arrivo di Mitsugu Okura, che dà una svolta molto più commerciale alla linea di produzione. È proprio su questa seconda fase, imperniata su un cinema di genere, che va dall’horror al noir, dal gangster movie all’ama (ragazze in bikini), che la selezione del Far East si focalizza, mostrando ben 15 film, la maggior parte dei quali sconosciuti e mai proiettati in Occidente. Da questo programma provengono senza dubbio le opere migliori proiettate al festival quest’anno. A partire da The Horizon Glitters di Doi Michiyoschi, resoconto di una rocambolesca evasione e di un viaggio alla ricerca di un fantomatico tesoro. Cinque criminali fuggono dal carcere, spinti dal desiderio di recuperare un bottino che uno di loro ha nascosto prima di venire arrestato: in un continuo alternarsi di momenti comici, episodi al limite del surreale, ed eventi di una ferocia estrema, i cinque protagonisti arrivano all’inesorabile scoperta della vanità della loro ricerca. Film di un nichilismo spiazzante, raccontato per buona parte con toni da farsa picaresca e impregnato a tratti di una tensione dionisiaca riflessa in un uso frenetico del montaggio, mette in luce come l’avidità e il miraggio della ricchezza riconducano l’uomo alla sua natura bestiale e ai suoi istinti primordiali.
 Ben cinque invece i film presenti in programma diretti da Ishii Teruo, conosciuto ai più per le sue opere ero-guro (erotiche-grottesche) degli anni Settanta. La sua prima produzione tuttavia, girata negli anni della sua permanenza alla Shin-Toho, guarda sorprendentemente al noir americano, riprendendone topos e stilemi e rielaborandoli in uno stile del tutto personale. Tra i migliori, Yellow Line e Black Line fanno parte di una serie di quattro film (la serie Line) che ha come tema principale il mondo della criminalità urbana. In Yellow Line, un killer senza nome, alter ego giapponese del Costello di Le samouraï di Jean Pierre Melville, tradito dal proprio mandante, cerca vendetta avvalendosi dell’aiuto di una giovane donna presa in ostaggio. Il film traccia il ritratto di un’esistenza condannata ad un’estrema solitudine, i cui tentativi di instaurare qualsivoglia relazione umana sono destinati necessariamente a fallire: non resta altro che abbandonarsi all’autodistruzione rivendicando la propria diversità e l’unicità della propria condizione. Black Line, invece, mescola sapientemente atmosfere oniriche e paesaggi urbani dando vita a un mondo profondamente realistico che improvvisamente si spalanca su scenari da incubo. Protagonista un giornalista che ha la sfortuna di risvegliarsi accanto al cadavere di una prostituta: incastrato, dovrà provare la sua innocenza trovando il vero assassino. L’abilità di Teruo si manifesta nella sua capacità di fondere sul piano visivo, e della messa in scena, sogno e realtà, riuscendo a mutare in modo repentino la connotazione semantica dei luoghi in cui il protagonista si aggira alla ricerca della verità: una strada deserta, una fabbrica di manichini sembrano allora non appartenere più a questo mondo, ma paiono rispondere ad una logica allucinatoria inestricabile dal labirinto cittadino in cui si svolge la vicenda. Ben cinque invece i film presenti in programma diretti da Ishii Teruo, conosciuto ai più per le sue opere ero-guro (erotiche-grottesche) degli anni Settanta. La sua prima produzione tuttavia, girata negli anni della sua permanenza alla Shin-Toho, guarda sorprendentemente al noir americano, riprendendone topos e stilemi e rielaborandoli in uno stile del tutto personale. Tra i migliori, Yellow Line e Black Line fanno parte di una serie di quattro film (la serie Line) che ha come tema principale il mondo della criminalità urbana. In Yellow Line, un killer senza nome, alter ego giapponese del Costello di Le samouraï di Jean Pierre Melville, tradito dal proprio mandante, cerca vendetta avvalendosi dell’aiuto di una giovane donna presa in ostaggio. Il film traccia il ritratto di un’esistenza condannata ad un’estrema solitudine, i cui tentativi di instaurare qualsivoglia relazione umana sono destinati necessariamente a fallire: non resta altro che abbandonarsi all’autodistruzione rivendicando la propria diversità e l’unicità della propria condizione. Black Line, invece, mescola sapientemente atmosfere oniriche e paesaggi urbani dando vita a un mondo profondamente realistico che improvvisamente si spalanca su scenari da incubo. Protagonista un giornalista che ha la sfortuna di risvegliarsi accanto al cadavere di una prostituta: incastrato, dovrà provare la sua innocenza trovando il vero assassino. L’abilità di Teruo si manifesta nella sua capacità di fondere sul piano visivo, e della messa in scena, sogno e realtà, riuscendo a mutare in modo repentino la connotazione semantica dei luoghi in cui il protagonista si aggira alla ricerca della verità: una strada deserta, una fabbrica di manichini sembrano allora non appartenere più a questo mondo, ma paiono rispondere ad una logica allucinatoria inestricabile dal labirinto cittadino in cui si svolge la vicenda.
 Per concludere, è di Nobuo Nakagawa la pellicola migliore proiettata al festival di quest’anno: il suo capolavoro, Ghost Story of Yotsusya, è quanto di meglio ci si poteva aspettare. Riprendendo un dramma ottocentesco del teatro Kabuki di Tsuruya Nanboku, Nakagawa mette in scena un kaidan eiga (storia di fantasmi) di assoluto rigore formale, essenziale ed astratto quanto basta per dare un significato universale a quanto viene mostrato sullo schermo. Nella storia del samurai che per sfrenato desiderio si macchia di una serie di efferati omicidi, esponendosi così alla vendetta dei fantasmi delle sue vittime, si rivela la tragedia dell’ambizione umana. In lunghi piani sequenza, con una macchina da presa che sembra spiare i suoi personaggi, in uno spazio che col procedere del film si fa sempre più geometrico ed irreale, Nagakawa ci mostra come i fantasmi che perseguitano il protagonista siano innanzi tutto i fantasmi della mente, che, sovrapposti ad ogni volto conosciuto, e nascosti in ogni anfratto del creato, si erigono ad emblema di un atto criminale irreversibile e condannano l’assassino all’eterna ripetizione di ciò che ha commesso. L’ossessione della colpa, da cui la fuga è impossibile, non offre tuttavia alcuna possibilità di redenzione, e nella magistrale sequenza finale, in cui il samurai si lascia andare ad un combattimento che assomiglia più ad una danza di morte, si può scorgere la profonda natura simbolica di tutta la vicenda narrata. Per concludere, è di Nobuo Nakagawa la pellicola migliore proiettata al festival di quest’anno: il suo capolavoro, Ghost Story of Yotsusya, è quanto di meglio ci si poteva aspettare. Riprendendo un dramma ottocentesco del teatro Kabuki di Tsuruya Nanboku, Nakagawa mette in scena un kaidan eiga (storia di fantasmi) di assoluto rigore formale, essenziale ed astratto quanto basta per dare un significato universale a quanto viene mostrato sullo schermo. Nella storia del samurai che per sfrenato desiderio si macchia di una serie di efferati omicidi, esponendosi così alla vendetta dei fantasmi delle sue vittime, si rivela la tragedia dell’ambizione umana. In lunghi piani sequenza, con una macchina da presa che sembra spiare i suoi personaggi, in uno spazio che col procedere del film si fa sempre più geometrico ed irreale, Nagakawa ci mostra come i fantasmi che perseguitano il protagonista siano innanzi tutto i fantasmi della mente, che, sovrapposti ad ogni volto conosciuto, e nascosti in ogni anfratto del creato, si erigono ad emblema di un atto criminale irreversibile e condannano l’assassino all’eterna ripetizione di ciò che ha commesso. L’ossessione della colpa, da cui la fuga è impossibile, non offre tuttavia alcuna possibilità di redenzione, e nella magistrale sequenza finale, in cui il samurai si lascia andare ad un combattimento che assomiglia più ad una danza di morte, si può scorgere la profonda natura simbolica di tutta la vicenda narrata.
|