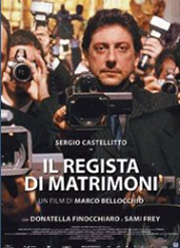



|
"L'artista vede ciò che i comuni mortali non vedono". L'interrogazione dell'immagine come veicolo di scoperta è uno dei grandi punti di forza di questa proteiforme opera di Marco Bellocchio. Il mestiere del cinema colto nella sue intermittenze, nel suo movimento incessantemente ondivago, strattonato tra libertà e costrizione. In quest'ottica la figura del regista di matrimoni, rappresentazione della conduzione registica di stampo protocollare, diventa emblema di un conflitto profondo che non si dà esclusivamente nel qui e ora, ma che pertiene all'origine stessa del fatto artistico.
È bene precisare subito che il film in questione non è un'opera concettuale. Non preesistono entità teoriche astratte che vengono poi "eseguite", bensì immagini che si svolgono nel fare cinema, nel loro concedersi allo sguardo registico e spettatoriale. L'artista ricorda, sogna, si appropria del reale con il suo produrre immagini e ne viene allo stesso tempo sopraffatto a causa dell'impossibilità di controllarne gli effetti, del suo essere a sua volta vittima di un occhio che lo spia. La microcamera nascosta nella giacca, la videocamera digitale, la macchina da presa di Bellocchio sono tutti dispositivi che trascolorano l'uno sull'altro, tutti portatori di una carica esegetica inevitabilmente parziale, ma nondimeno ricca di una straripante distruzione creatrice. La moltiplicazione dei punti di vista diventa così rappresentazione della multiformità del visibile e, allo stesso tempo, incarna l'impossibilità di pervenire ad un punto unico di osservazione, ad una prospettiva certa da cui scrutare le cose, ad un'unica direzione dello sguardo. Lo sgretolamento dell'unitarietà della visione si travasa perciò in un meta-cinema vivo, che assume i conflitti come strumento d'indagine e che rifugge dalle separazioni tra finzione e realtà, tra vita e recitazione, tra dimensione conscia e inconscia. Le contraddizioni del campo/controcampo, i frequenti inserti metaforici, la radicalità nell'uso del contrasto tra luci ed ombre, la recitazione che travalica i suoi confini finzionali e l'aspra critica contro la parzialità del giudizio degli esperti di cinema e della società tutta, sono solo alcuni degli elementi che emergono dal film. In realtà si tratta di un'opera eminentemente autoreferenziale, nell'accezione più alta del termine. Non di rado, infatti, ci si accorge della presenza di un citazionismo orgogliosamente autoriferito (Salto nel vuoto, L'ora di religione, La macchina del cinema…), che approfondisce il discorso sul fare film, arricchendolo di collegamenti utili a cogliere l'opera come parte di un discorso unitario sul cinema, che per Bellocchio si è spesso delineato come passionale battaglia alla ricerca dell'Immagine.
Lungo la struttura drammatica - che potremmo definire di origine fiabesco-psicanalitica - si dipanano, dunque, temi e forme da sempre cari al regista piacentino. L'amore assume le forme di una conquista difficile, legata alla tensione verso un oscuro oggetto del desiderio che non può mai trovare piena soddisfazione. La volontà di salvare la novella Lucia dal suo destino di segregazione clericalmatrimoniale si scontra con l'assopimento dell'immaginazione, unica forma di libertà da costrizioni perpetrate nel nome del padre. Come spesso nei film di Bellocchio, anche qui si intravede un discorso sulla libertà e sull'alterità. L'eterno conflitto dell'individuo con se stesso e con gli altri si riflette nel rilancio dell'autorialità come ricerca di senso che lascia spazio a vuoti semantici e a pura casualità. Corsi e ricorsi della visione filmica per un'opera capace di mettersi in gioco e di recuperare quindi la consapevolezza che il cinema ci (ri)guarda.
|