

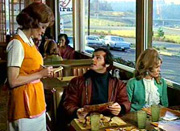
|
Noi spettatori dell'America
conosciamo soprattutto quei luoghi che il cinema ha saputo
o voluto trasmetterci, offrendoceli molto più che
come una semplice indicazione geografica.
Risale in superficie il significato
letterale della parola topos, che è innanzitutto,
appunto, un luogo, e che solo in un secondo momento
diventa un luogo comune, una figura riconoscibile
e fortemente connotata che riconduce ogni immagine alla
propria tradizione. Il cinema è avvezzo ad adoperare
il concetto di cronotopo, un apparato spazio-temporale
legato in modo indissolubile alle vicende narrate, in
cui lo sfondo diventa protagonista di una storia, al pari
degli attori, e le caratteristiche dell'uno si trasferiscono
agli altri. E viceversa. È il caso degli spazi
ostili in cui si muovono gli uomini duri e disperati dei
western o delle superfici lucide e mobili che costituiscono
le città in cui si sviluppano le tragiche vite
dei personaggi dei noir.
Negli anni Sessanta il luogo per
eccellenza è rappresentato dalla strada. Con la
pubblicazione, nel 1957, di On the road di Jack
Kerouac, prende avvio la produzione di libri, film, canzoni
che hanno proprio il viaggio come fulcro narrativo. Con
la nascita della beat generation vede la luce anche
una generazione desiderosa di un incessante movimento.
Alla stessa genia appartiene Robert Eroica Dupea, il protagonista
di Cinque pezzi facili. La sua famiglia, di origine
alto-borghese, vive su di un'isola silenziosa e separata
dal resto del continente, ed è interamente dedita
alla musica. Robert ha abbandonato una promettente carriera
di pianista e la sua ricca casa in cerca di qualcosa d'altro.
La sua ribellione è quella di un'intera generazione
che ha scelto di non poter più continuare ad ignorare
la realtà, di considerare mortifero il dorato isolamento
assicurato dalla propria nascita. Per molti giovani di
quegli anni, il contatto con un modello di vita alternativo
fu offerto dalla partecipazione alle contestazioni studentesche.
Per Robert è invece costituito dalla scelta, consapevole,
di un lavoro umile, da operaio, e dalla convivenza in
uno squallido motel con una cameriera vacua e triste.
Ma egli, tuttavia, si scopre insofferente anche a questo
sistema di vita. Non riesce a riconoscersi in nessuna
delle persone che lo circondano, quale che ne sia la classe
sociale di appartenenza, e con nessuno riesce a comunicare,
sebbene il suo essere legato contemporaneamente a due
mondi diversi gli fornisca una molteplicità di
codici. Non c'è condivisione di sentimenti nel
rumore o nella musica, nel silenzio o nelle parole che
rivolge a tutti coloro che incontra sulla propria strada.
Cinque pezzi facili, come altri film dell'epoca
d'altronde, è stato attaccato dalla critica cinematografica
di sinistra, italiana ed europea. Un atteggiamento, questo,
dovuto all'incapacità di comprendere che la ribellione
giovanile ha avuto origini e sviluppi diversi in Europa
e negli Stati Uniti. Di stampo politico e sociale nel
primo caso, strettamente legata all'individuo nel secondo.
Tutto ciò di cui si va alla ricerca, in quella
che usa autodefinirsi la terra della libertà, è
proprio l'essere liberi: la possibilità di seguire
un impulso, abbandonare l'automobile in cui si è
prigionieri del traffico, salire su un camion per traslochi
di cui non si conosce la destinazione, sedersi ad un pianoforte
polveroso, suonare in modo sublime tra clacson e grida
andando incontro all'orizzonte.
La decisione è lasciata alla
discrezione dello spettatore: la strada è il segno
di una rivoluzione fallita, e dell'alienazione che ha
generato, o dell'impossibilità di smettere di ribellarsi? |